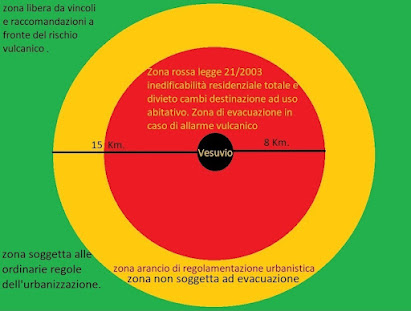Nei Campi Flegrei, alcuni eventi sismici a bassa magnitudo
ma con un trend energetico al rialzo, hanno destato non poche perplessità nei
550.000 dimoranti che popolano la caldera del super vulcano flegreo. I
residenti si chiedono, senza esagerate apprensioni, se i tempi incominciano ad
essere maturi per il passaggio dalla fase di attenzione a quella di pre
allarme.
Dal punto di vista delle istituzioni, la direttrice
dell’Osservatorio Vesuviano in un intervento rimandato sui social, ha confermato
che in realtà quelle flegree sono energie sismiche che si sviluppano per
bradisismo e che producono terremoti modesti, anche se a volte vengono avvertiti
nettamente nel comprensorio flegreo. Gli eventi, continua la responsabile napoletana
dell’INGV, si localizzano prevalentemente intorno ai 2 Km. di profondità, in
quella che è l’area sismogenetica compresa tra la Solfatara e le emissioni di Pisciarelli.
Gli altri parametri geofisici e geochimici del vulcano, precisa la dott.ssa
Bianco, non sembrano denotare variazioni significative. Tra l’altro il
monitoraggio in continuo effettuato dall’osservatorio vesuviano, non presenta
segnali che possano eventualmente indicare dinamiche ascendenti del magma con
annessa possibilità d’innesco di una eruzione. In conclusione, la dirigente rassicura
e segnala che Il fenomeno del bradisismo al momento non è correlabile con un aumento
della pericolosità vulcanica, ma con l’andare del tempo le deformazioni del
terreno potrebbero incidere sulla resistenza statica degli edifici.
Parole perlopiù confortanti e in linea con le FAQ pubblicate
nelle pagine web INGV dello stesso osservatorio vesuviano. Quivi la prima
domanda ad oggetto giustappunto la previsione degli eventi vulcanici, contiene elementi molto confortevoli, che ad ogni buon conto riportiamo integralmente:
Domanda: È possibile prevedere la prossima eruzione del Vesuvio
o dei Campi Flegrei? Risposta. Non è possibile prevedere a lungo
termine quando ci sarà la prossima eruzione. Tuttavia, grazie alla sorveglianza
del vulcano è possibile rilevare con ampio anticipo l'insorgenza di
fenomeni precursori, che generalmente precedono un'eruzione, e procedere
all'evacuazione prima che avvenga l'eruzione.
Secondo il nostro punto di vista, la parola ampio anticipo utilizzata dall'osservatorio vesuviano è in contrasto con i contenuti della direttiva della presidenza del consiglio (12/02/2021), che segnala la necessità di pubblicizzare i limiti scientifici delle previsioni probabilistiche. Lo stesso dipartimento della protezione civile però, ripete che le applicazioni di tipo probabilistico sono possibili solo per alcune fenomenologie che caratterizzano i vulcani attivi in forma permanente, ad esempio l’Etna e lo Stromboli. La lettura dell'articolo precedente chiarisce questi aspetti.
Nel campo della previsione degli eventi vulcanici, occorre
dire che le eruzioni in genere possono essere preannunciate da fenomeni anche
minimi monitorabili da strumentazioni ad alta tecnologia, compresa quella
satellitare. Il problema grosso però, è dettato proprio dalla sensibilità degli
strumenti, che possono registrare una condizione anche minimale di “irrequietezza” del magma
con tutti i suoi prodotti liquidi e gassosi di cui è intriso, che accompagnano anomalie
geochimiche e geofisiche, a cui non sempre corrisponde un allarme. Quindi: l’elevata tecnologia può solo anticipare la fase di
attenzione, ma nulla può dirci sulla previsione dell’evento vulcanico che rimane
ancorato a valutazione e tempistiche tutte umane, corroborate da basi statistiche molto limitate per il Vesuvio e ancora di più per i Campi Flegrei.
Interpretare allora, è la parola chiave proposta e richiesta
alla commissione grandi rischi, che dovrà pronunciarsi, carte alla mano,
sui risultati del monitoraggio vulcanico, con responsi difficilissimi da trarre
da semplici dati per quanto accurati, che potranno oscillare su un ventaglio di possibilità che partono da innocui riequilibri profondi del
magma a possibili e allarmanti condizioni pre eruttive. In tutti i casi non è
l’osservatorio vesuviano che decide i livelli di allerta vulcanica, ma la
commissione grandi rischi per il rischio vulcanico, atteso che a un livello
di allerta superiore ad attenzione (giallo), corrisponde un importante corrispettivo operativo e amministrativo. Ricordiamo ancora una volta che il pulsante per l'evacuazione, quello rosso, è pigiabile solo dal premier: nell'attualità Mario Draghi. Di seguito i livelli attuali stabiliti dall’autorità
scientifica:
In realtà, in assenza di soglie limite strumentali di riferimento, riferite a valori numerici codificati, il passaggio ascendente o discendente da uno dei 4 colori illustrati, sono legati a fattori umani. Precisiamo che le uniche due colorazioni che non è difficile determinare, sono quella verde e giallo, perché non prevedono azioni per la popolazione. La più difficile in assoluto è proprio quella del pre allarme (arancione), mentre per quella rossa temiamo prodromi probabilmente avvertiti direttamente dalla popolazione. Una condizione quest'ultima, non contemplata nei piani d'emergenza, ma che può essere la circostanza capace di alterare in negativo i comportamenti umani (panico), con tutto ciò che ne consegue, soprattutto in un contesto evacuativo organizzato secondo formule da gita aziendale.
La valutazione dei tempi che segnano e accompagnano la previsione eruttiva nei Campi Flegrei e del Vesuvio, nelle carte dicevamo è molto rassicurante. Ampio anticipo riferisce l’osservatorio vesuviano: 72 ore riferiscono invece le istituzioni politiche e tecniche. Il presidente della Regione Campania De Luca, molto pragmaticamente disse che questi tre giorni a disposizione per l’evacuazione potrebbero esserci, ma potrebbero anche non esserci…. In realtà, da un punto di vista strettamente tecnico, se la previsione dell’evento vulcanico fosse possibile in un ambito ottimistico di ampio anticipo, non ci sarebbe nel percorso operativo la fase dubitativa diversamente chiamata di pre allarme, dove i cittadini che ne sentissero la necessità, potrebbero allontanarsi spontaneamente usufruendo pure di un contributo statale di autonoma sistemazione. La fase di preallarme consente in ultima analisi al cittadino, di scostarsi dalle indecisioni scientifiche, assumendo con propria iniziativa la responsabilità di allontanarsi dalla zona rossa.
Quanti terremoti e con quali intensità possono essere interpretati come precursori di eruzioni? E quali sono le concentrazioni di gas e le temperature e le deformazioni limiti del suolo quali sintomi prodromi dell’eruzione? Nessuno lo sa! Perchè le variabili d'intreccio di questi dati, possono essere numericamente considerevoli, ma in tutti i casi con combinazioni mai verificate, per esempio per apparati come i Campi Flegrei la cui ultima eruzione risale al 1538. Non ci sono elementi di comparazione per azzardare una previsione, non solo perché non abbiamo dei database di riferimento che vanno indietro per decine di secoli, ma anche perché ogni vulcano ha delle caratteristiche proprie non sovrapponibili in genere a qualsiasi altro vulcano.
Ci sembra il caso di chiedere un parere al
Professor Giuseppe Mastrolorenzo, primo ricercatore presso
l’osservatorio vesuviano, molto presente con le sue spiegazioni sui media
nazionali e internazionali.
Professore, ai Campi Flegrei come al Vesuvio è
possibile prevedere un’eruzione con ampio anticipo?
Se il “largo anticipo“ è inteso come un tempo ampiamente superiore a quello necessario a garantire la messa in sicurezza di tutte le comunità a rischio, la risposta è certamente no. Ho dovuto ricordare, come spesso ho evidenziato, anche con rapporti ad organi Istituzionali e di Protezione Civile, come la previsione di eruzioni, in vulcani, come il Vesuvio e i Campi Flegrei sia impossibile.
L’intrinseca imprevedibilità deriva dalla complessità dei
sistemi vulcanici a tutti i livelli, dalla sorgente magmatica alla superficie,
dai processi fisici, chimico-fisici a diverse scale spaziali e temporali, che
controllano complessi processi di genesi ed evoluzione del magma e della sua
risalita verso la superficie.
Tali processi, così come i parametri coinvolti, sono solo ipotizzabili,
sulla base delle indagini geofisiche e vulcanologiche, svolte principalmente
negli ultimi decenni. A tali limiti, si aggiunge la natura caotica dei processi,
la cui evoluzione può variare drasticamente in funzione di minime variazioni dei
parametri, fuori dalla portata di qualsiasi indagine scientifica.
In altri termini, anche se la crosta terreste fosse
totalmente trasparente e potessimo vedere il magma e definirne le proprietà in ogni punto, non
saremmo in grado di prevedere un’eruzione e la sua intensità.
Ma la crosta è tutt’altro che trasparente, e le nostre conoscenze sono indirette e quasi esclusivamente basate su ipotesi e modelli descrittivi, spesso in contrasto tra loro, e più o meno sostenute da pochi parametri misurabili. Anche se disponessimo di esperienza diretta di un grande numero di crisi eruttive monitorate in ogni fase, resterebbe comunque imprevedibile una futura eruzione.
Premettendo una camera magmatica ubicata a circa 8 km. di profondità per entrambi gli apparati vulcanici citati, è assodato scientificamente che il magma prima di assurgere in superficie deve saturare camere magmatiche superficiali ubicate a 3-4 km. di profondità?
Anche il dibattito scientifico riguardo la profondità del magma
prima degli eventi eruttivi rientra nella più generale tematica della modellistica
vulcanologica, basata su dati indiretti, principalmente di natura magmatologica
e geofisica.
Studi sulle rocce vulcaniche di eruzioni avvenute in
passato, hanno indotto alcuni autori a ipotizzare uno stazionamento del magma a
profondità di alcuni chilometri, per una successiva evoluzione pre-eruttiva. Tale processo
è stato ipotizzato principalmente in relazione alle maggiori eruzioni del
Somma-Vesuvio, e solo vagamente per i Campi Flegrei e per eruzioni minori.
Per quanto gli studi in merito rivestano un notevole interesse
scientifico, sarebbe un vero azzardo affidare la sicurezza di milioni di
persone all’ipotesi di un prolungato arresto della risalita del magma ad una
profondità intermedia, per un tempo prolungato prima dell’evento eruttivo. La sosta di questa massa magmatica fusa, potrebbe consentirne la facile
identificazione, e quindi in assenza di tali evidenze, per ragionamento inverso si è portati ad escludere
una eruzione.
Di fatto, quello dell’accumulo superficiale del magma, per lungo
tempo, prima di una eruzione, resta solo un modello o un’ipotesi di lavoro, e
non deve essere adottato a fini di sicurezza e protezione civile. In realtà, con le tecnologie attualmente disponibili, può risultare critica anche l’individuazione
di un
processo di risalita
magmatica, che può
manifestarsi attraverso
fratture nella crosta,
di dimensione di alcuni
metri, ed evolversi rapidamente
con sismicità modesta e segnali, quali
deformazioni del suolo ,
variazioni di accelerazione di gravità locale, flusso di gas e di calore, difficilmente rilevabili,
almeno nelle prime fasi
del processo di risalita ,e magari anche
in quelle immediatamente
precedenti l’eruzione .
Ed è proprio questo, lo scenario che prudenzialmente deve
essere considerato, mentre le ipotesi che prevedevano ottimisticamente evidenti
precursori e manifestazioni rilevabili della risalita del magma, seppure
scientificamente validi, comportano, se adottati a fini di protezione civile,
un azzardo inaccettabile.
Contrariamente, lo scenario di una risalita “silenziosa” del
magma, attraverso sottili condotti, non rilevabili, attraverso il monitoraggio
geofisico e geochimico, comporta la concreta possibilità di un mancato allarme
o di un allarme solo a eruzione in corso o imminente. Di conseguenza, anche una
evacuazione in frangenti eruttivi, deve essere
considerata e pianificata: questa eventualità non è considerata nei
piani di emergenza. La statistica ci pone di fronte all’evidenza di non pochi casi registrati nel mondo, di evacuazioni avvenute con eruzione in corso, dettate da vulcani esplosivi
e non, tra l’altro sottoposti a sistemi di monitoraggio avanzati e piani di
emergenza mirati.
Il bradisismo flegreo può essere considerato un fenomeno
che non riguarda direttamente le caratteristiche vulcaniche dell’area? Se
l’ascesa del suolo dovesse continuare bisognerà preoccuparsi dei terremoti e
quindi della statica dei palazzi o del pericolo vulcanico che avanza?
L’attività sismica,
associata all’attuale fase bradisismica, costituisce certamente un fondamentale
indicatore dello stato e dell’evoluzione del sistema vulcanico, anche se per
quanto detto di difficile interpretazione.
Coesistono modelli contrastanti sulle cause e la possibile
evoluzione del bradisismo, ma in generale, la sismicità è interpretata come un effetto
diretto del rilascio dello stress, prodotto dalla deformazione degli ultimi
chilometri della struttura calderica per complessi processi di circolazione dei fluidi all’interno del
sistema geotermico, verosimilmente a causa di modificazioni nel sistema magmatico
sottostante e/o della permeabilità dello stesso sistema geotermico.
L’esperienza delle passate crisi bradisismiche, suggerisce che la sismicità, e lo stesso bradisismo, non sono necessariamente precursori di eruzioni. In tempi storici, infatti, l’unico caso di eruzione a seguito di una prolungata fase bradisismica, è quella del Monte Nuovo nel 1538. Ma è superfluo ribadire, come nessuna valutazione probabilistica può avere senso per sistemi con così ampie lacune conoscitive.
Circa il rischio direttamente connesso con la sismicità,
questo è risultato modesto nelle passate fasi bradisismiche, fino a magnitudo
di poco superiori al quarto grado Richter. Ma è evidente, come dati gli elevati
valori di accelerazione locale, dovuta alla bassa profondità ipocentrale,
nonché alla diffusa disomogeneità dei terreni interessati, si renderebbe necessaria una valutazione accurata delle condizioni statiche degli edifici pubblici
e privati, nell’intera area calderica dei Campi Flegrei, dei settori occidentali
dell’area urbana napoletana e dei comuni limitrofi.
Il Professor Mastrolorenzo ha espresso con chiarezza il suo pensiero scientifico circa la previsione degli eventi vulcanici e la variante bradisismica. Di questo lo ringraziamo.
Da un punto di vista tecnico invece, occorre ricordare che
non ci sono strumenti per quanto tecnologicamente avanzati, capaci di apportare sicurezze matematiche al vivere quotidiano delle popolazioni esposte al rischio vulcanico, tanto nel vesuviano quanto nei Campi Flegrei.
Purtuttavia è necessario avere contezza del rischio areale, ma poi occorre avere pure l’arguzia per comprendere che se da un lato la nostra corsa
verso la conoscenza dei fenomeni vulcanici ad un certo punto si ferma per
raggiunti limiti conoscitivi, nulla ci vieta di essere civicamente e criticamente presenti sul territorio, favorendo politiche organizzative, strutturali e infrastrutturali, capaci di mettere per
quanto possibile in sicurezza la terra dove viviamo. Un territorio quello flegreo, che non potrà essere ancora oltre sovraccaricato di abitanti, magari adottando il prima possibile un vincolo di inedificabilità totale residenziale nella zona rossa, alla stregua di quanto fatto per il Vesuvio. Il sindaco Manfredi intanto deve sciogliere il rebus Bagnoli...
di Vincenzo Savarese