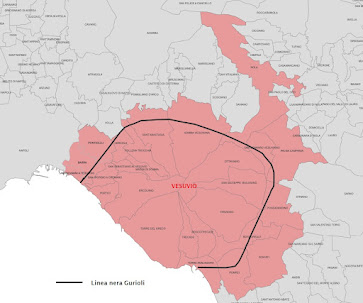|
| The islands flegree |
Naples, the Vesuvius and the Phlegraean Fields
The
province of Naples is characterised by the three volcanic complexes of the
Vesuvius, the Phlegraean Fields and the island of Ischia. Despite their
closeness to each other, each of them has completely different characteristics
as well as dissimilar form and extention.
The
Vesuvius, the most famous of the three, easily recognisable by its distinctive
shape and profile, gave rise to the most famous eruption in history. In 79 AD a
plinian explosive eruption buried the
cities of Pompeii and Herculaneum thus providing us with a significant part of
the world’s archaeological heritage. This was, however, only one of many
eruptions the last of which took place in 1944.
The island of Ischia is
the upper part of a submarine volcano. About 55,000 years ago a violent
explosive eruption took place known as the green tuff stone of Epomeo; the most
important in terms of intensity and morphological transformation, its violence
created a caldera which was invaded by the sea and later filled with the
accumulation of piroclastic material that erupted from numerous eruptive vents
on the island.
Mount Epomeo is not a volcano but rather a sort
of tuff stone column pushed up by the magma beneath. At an altitude of 787
metres, it is the highest point on the island. On the eastern side of its base
are numerous eruptive centres, the
product of past effusive and explosive activity that has often taken place
after long periods of quiescence. The last eruption was that of the Arso which
took place in 1302 AD. Today, the island has important hydrothermal and
fumarolic activity which is the manifestation of an uncalmed activity beneath
the ground. A few years ago a loud rumble on the side of Forio caused alarm but
it turned out to be only a vapour jet which had been suddenly released from
beneath the hillside.
Tuff stone
is easily eroded by the elements – wind, sun and water. This explains the vast
number of boulders balanced precariously on the steep slopes of Monte Epomeo. An
earthquake could easily shake the ground and cause them to tumble down the
mountain. Amazingly enough, one of the biggest of these did fall down in the
past and was then chiselled and sculpted into a house which is now inhabited.
 |
| Monte Nuovo (1538) |
 |
| Cava sotterranea di tufo giallo appena scoperta in località Piscinola (NA) |
This
incredible network of water canals, cisterns and wells which reached
courtyards, and stairwells within houses needed maintenance from workers
called the ‘pozzari’. To work in such narrow spaces they
needed to be of small stature. They wore a light covering of sacking as
protection from the cold and as protection for their clothes which would
otherwise have been torn by scraping against the stone walls of the narrow
shafts. It is likely that the figure of the ‘pozzaro’ gave rise to the legend of the ‘monaciello’ the ethereal
child, generous if at times also mischievous,
so beloved by Neapolitans. The ‘monaciello’ however, is found not
only in Neapolitan folk tradition but all along the Sorrento coast where there
are also banks of tuff stone that have been perforated with shafts and wells. And so we always leave a little piece
of bread on the table after dinner for him…
The grey tuff stone of Sorrento
was produced by the fall of pyroclastic material from the Phlegraean Ignimbrite
eruption (Archiflegreo). Surface lithoid banks are visible, above all, in
cliffs overlooking the sea. Caves dug out over the centuries to extract stone
for building and used as shelters or boat yards (monazeni) can also still be
seen from the sea.
The
figure above shows the "eye of the mountain", the initial, circular
part that is dug out, widening as it descends, forming a bell shape. Stairs cut
into the stone walls are also visible with signs of soot left by oil lamps.
 |
| Tratto dell'acquedotto romano sotterraneo che adduce a una cisterna in zona Chiatamone (NA) |
In 1629 Don Cesare Carmignano, assistant to the engineer Alessandro Ciminello, designed the enlargement of
the aqueduct, by now inadequate to satisfy the increasing needs of the city. He
provided it with new waters extracted from Sant'Agata dei Goti in the Benevento
area. Known as the Carmignano after its planner, it remained in use until 1885
after which it was closed up following the numerous epidemies that hit the
city.
The
tuff stone, literally showered on the city by explosive volcanic eruptions
together with lapilli and pozzolana were to be irreplaceable building materials
while the incomparably fertile soils still provide nourishment for precious
vines, fruit trees and tomatoes. Tuff stone has been transformed into tombs,
cisterns, temples, castles, cathedrals and aqueducts. It has served to build
city walls and fortifications. In the Second World War the subsoil of Naples
was used for air raid shelters which saved the lives of hundreds of people.
The
salubriousness of the Phlegraean Fields and the fertility of its soil still
make it, together with the Bay of Naples a desirable destination for a cultured
tourism that wishes to relive the splendours of Roman civilisation.
Neapolitans
live out a strange relationship with their volcanoes, debateable and illogical,
but also romantic and fatalistic. A bond that today is particularly difficult,
given the excessive increase in population that instead of proliferating far
from eruptive vents has created a demographic stranglehold around them. Like
living in front of a cannon barrel; safety will depend on the length of the
fuse and how early on we will be able to see the spark!
Translation: by Lisa Norall
Translation: by Lisa Norall