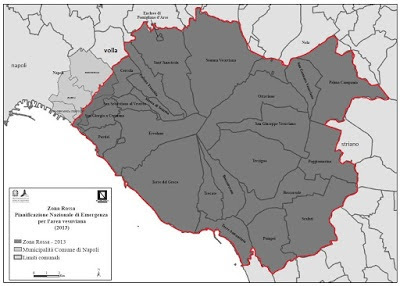|
| Vesuvio da Torre Annunziata |
Il
Vesuvio è un famosissimo vulcano che per il passato ha dato vita a eruzioni di
diversa intensità, anche di tipo esplosivo (pliniana), come quella che nel 79
d.C. devastò e seppellì le città di Pompei, Ercolano, Stabia e Oplontis: oggi
siti archeologici d’importanza mondiale.
Quando
un vulcano come il Vesuvio produce un’eruzione esplosiva, forma una colonna
eruttiva che spara letteralmente in aria una gran quantità di prodotti
piroclastici di varie misure, misti a gas e vapori, che possono raggiungere
nelle tipologie pliniane anche i 30 Km. di altezza.
 Da
questa colonna scura e minacciosa che s’innalza nel cielo accompagnata da scariche
elettriche, in genere e dopo poco, si staccano masse di prodotti che, ricadendo
lungo i fianchi del vulcano, si trasformano in colate piroclastiche: una sorta
di valanghe travolgenti, con ammassi che scorrono velocemente con temperature
oscillanti tra i 300° e i 600° Celsius.
Da
questa colonna scura e minacciosa che s’innalza nel cielo accompagnata da scariche
elettriche, in genere e dopo poco, si staccano masse di prodotti che, ricadendo
lungo i fianchi del vulcano, si trasformano in colate piroclastiche: una sorta
di valanghe travolgenti, con ammassi che scorrono velocemente con temperature
oscillanti tra i 300° e i 600° Celsius.
Alcune
simulazioni hanno consentito di stimare in meno di dieci minuti il tempo
occorrente a una colata piroclastica per raggiungere sul versante sud
occidentale del Vesuvio il mare.
Pericolosissimi
sono anche i lahar, cioè colate rapide, in questo caso di fango, che si
sviluppano quando l’acqua espulsa dall’eruzione sotto forma di vapore, condensa
e si mescola alla cenere vulcanica, scivolando impetuosamente lungo i valloni
erosivi che segnano il monte, per poi dilagare a valle con impeto, dando così
spazio agli alluvionamenti melmosi.
La
terza e non meno pericolosa manifestazione vulcanica, è quella della pioggia di
cenere e lapilli, che andrebbe a interessare soprattutto la zona posta
sottovento al vulcano, con potenze di deposito inversamente proporzionali alla
distanza dal cratere. La cenere, con la sua componente vetrosa, oltre a creare
difficoltà alla respirazione e alla circolazione dei veicoli e velivoli, riduce
anche la visibilità. Accumulandosi poi in gran quantità sui tetti non
spioventi, potrebbe determinare lo sprofondamento dei solai di copertura e a
seguire quelli di piano. Inoltre, gli accumuli di prodotti piroclastici nella
parte più alta degli edifici, potrebbero rendere i fabbricati maggiormente
vulnerabili alle oscillazioni indotte dai terremoti, a causa dell’anomalo
sovrappeso in sommità.
Le
lave si presentano raramente nelle eruzioni esplosive; in ogni caso non
rappresenterebbero un problema per l’incolumità delle persone, ma solo per le
case e altri manufatti che si trovano lungo il percorso. Tra l’altro i flussi
lavici sono praticamente incontenibili e difficilmente deviabili.
La
cartina che vi mostriamo in basso, evidenzia quelle zone vesuviane e
provinciali a differente pericolosità, a iniziare da quella più problematica in
assoluto: la zona Rossa 1 (R1). Trattasi della prima area concentrica
all’apparato vulcanico, che può essere invasa dalle colate piroclastiche, dai
surges piroclastici, dalle colate di fango, e inoltre il settore diventerebbe
bersaglio di imponenti ricadute di blocchi, bombe e lapilli.
La
zona Rossa 2 (R2) invece, è quella parte del territorio vesuviano ubicata a est
del cono vulcanico, dove, per effetto dei venti dominanti spiranti, secondo
elementi statistici, prevalentemente in quella direzione, è maggiore il rischio
di massiccia ricaduta di cenere e lapilli con tutti i problemi che ne
concernerebbero per la sicurezza, la visibilità e la mobilità dei cittadini.
La
zona gialla è quella parte piuttosto estesa del territorio esterno alla zona
rossa nel suo complessivo, dove in caso di eruzione si concretizzerebbero
problematiche da accumulo di cenere in una misura presumibilmente minore
rispetto alla zona R2. In ogni caso le conseguenze per la popolazione sarebbero
rapportate alla distanza dal centro eruttivo e dalla direzione e intensità del
vento in quel momento. Eventuali provvedimenti cautelativi, secondo le
strategie adottate dalle autorità competenti, andrebbero assunti durante
l’eruzione, dopo che si sia avuta contezza del settore territoriale
maggiormente coinvolto dalla pioggia di cenere e lapilli.
Nella
foto sottostante, il campo d’aviazione americano di Terzigno durante l’eruzione
del Vesuvio del 1944. La pioggia di piroclastiti rese impraticabile l’aeroporto
e danneggiò seriamente gli aerei che non ebbero il tempo di decollare.
 |
| 1944 - Terzigno - Campo di volo americano "bombardato" dal Vesuvio |
La
zona blu comprende quei territori in zona gialla a nord del Vesuvio,
altimetricamente classificabili depressi (conca di Nola), che in seguito
all’eruzione potrebbero essere allagati e sommersi da oltre 2 metri d’acqua e
fango. Non c’è ancora una chiara strategia operativa a difesa delle popolazioni
che dimorano in zona blu, tra Acerra e Nola. L’entità del fenomeno comunque,
avrebbe uno stretto rapporto con i depositi di cenere sottili capaci di impermeabilizzare
i suoli. Anche in questo caso quindi, la direzione dei venti e l’entità della
pioggia di cenere e lapilli condizionerebbe la vulnerabilità di questo settore,
purtroppo in scarsa evidenza nei piani d’emergenza.
Un
ulteriore elemento di pericolo intrinseco alle eruzioni, è dettato dai
terremoti. Infatti, le eruzioni di solito sono precedute da sussulti sismici di
tutto rispetto, con scosse e tremori che si manifesterebbero sia nella fase
prodromica ma anche in modo piuttosto acuto durante l’eruzione.
La
previsione delle eruzioni
Occorre
subito dire che non è possibile prevedere sul lungo termine quando ci sarà
un’eruzione del Vesuvio. A detta degli esperti, auspicabilmente i segnali
geofisici e geochimici che si manifesteranno e anticiperanno l’approssimarsi
del fenomeno eruttivo, possono essere immediatamente colti, grazie a una
sorveglianza vulcanica diuturna, e potrebbero consentire di formulare, in una
chiave probabilistica che andrebbe a perfezionarsi con il passare delle ore,
una previsione corta o cortissima del fenomeno, cioè sul breve e brevissimo
tempo. Nella fattispecie del discorso, possiamo parlare di ore, giorni e forse
settimane.
Il
tempo intercorrente tra l’insorgere degli indicatori di variazione dello stato
di quiete del vulcano e la ripresa eruttiva, rimane quindi una incognita di
fondamentale importanza per la componente tecnico politica deputata alla
diramazione dell’allarme, e quindi alla salvaguardia delle popolazioni.
È
opportuno precisare che la previsione anche corta come innanzi dicevamo, avrà
sempre un taglio probabilistico e mai deterministico, perché la certezza
dell’eruzione ci sarà data solo dall’effettiva e tangibile ripresa del fenomeno
in tutta la sua virulenza energetica.
In
altre parole, il rischio del mancato allarme o del falso allarme sono fattori
che non è possibile azzerare in quello che è un ambito disciplinare scientifico
(geologia) zeppo di incognite derivanti da un ambiente senza un orizzonte di
visibilità, purtuttavia dinamico e in ogni caso inesplorabile direttamente
dall’uomo. Le perforazioni hanno raggiunto con grande difficoltà i dieci
chilometri di profondità che sono ben poca cosa rispetto a un raggio medio
terrestre di 6370 km.
Prima
di lanciare l’allarme eruzione quindi, anche alla luce della grande quantità di
persone da mobilitare, bisognerà attendere qualcosa di più concreto delle prime
avvisaglie di irrequietezza vulcanica, perché talune variazioni potrebbero
essere sintomi di ripristino degli equilibri interni dell’apparato vulcanico,
magari dettati da semplici sommovimenti o modeste intrusioni magmatiche in
profondità.
D’altra
parte le filosofie della sicurezza inducono ovviamente a ritenere maggiormente
accettabile un falso allarme, anche se il medesimo non è scevro da rischi,
perché metterebbe in moto un gran numero di cittadini, in un contesto
ambientale fatto di assetti stradali modesti e non congeniali alla
movimentazione rapida della popolazione vesuviana. Da questo punto di vista
la fascia litoranea che è anche quella ad alta densità abitativa, presenta le
maggiori criticità perché la popolazione è stretta tra mare e monte.
Va
ricordato inoltre, che la diramazione dell’allarme eruzione non è a cura
dell’autorità scientifica ma di quella politica ai massimi livelli (Presidenza
del Consiglio).
La
zona rossa sancita da un apposito decreto, è rappresentata dall’insieme delle
zone R1 e R2 (vedi immagine sottostante): trattasi dell’area di totale
evacuazione della popolazione, ma anche dei soccorritori in caso di allarme
vulcanico. La differenza sostanziale tra le due zone non sono le modalità di allontanamento preventivo, ma la disomogeneità delle attività di prevenzione delle catastrofi...
Le
strumentazioni di monitoraggio vulcanico
Le
strumentazioni ipertecnologiche e super sofisticate di monitoraggio del
Vesuvio, gestite dall’Osservatorio Vesuviano (INGV), aiutano nella decifrazione
dello stato del vulcano, ma non sono la soluzione dell’incognita previsionale.
La tecnologia da terrestre a satellitare, serve ad anticipare la cattura dei
sintomi di irrequietezza vulcanica, ma nessun strumento è in grado di dire a
che cosa porteranno quelle variazione dei parametri vulcanici così precocemente
captati dagli strumenti.
Una
strumentazione di alto o altissimo livello infatti, può solo anticipare lo
stato di attenzione vulcanica, ma non aiuta ad anticipare la valutazione sulla
dichiarazione dello stato di allarme, che sarà un’azione decisionale complessa
ma necessariamente tutta umana, presumibilmente frutto di pareri
interdisciplinari e di analisi del rischio nella sua complessità.
A
corredo del discorso, occorre segnalare pure un’ulteriore incognita di non poco
conto che ha sparigliato i teoremi della prevenzione delle catastrofi collegate
al Vesuvio. Nonostante riteniamo che sia auspicabilmente abbordabile la
previsione corta del fenomeno eruttivo, in realtà nessuno è in grado di
stabilire dai sintomi captati o anche percepiti direttamente dall’uomo, quale
sarà la taglia eruttiva (VEI) dell’eruzione che verrà! Cioè quante energie
diromperanno dal sottosuolo vesuviano... Nel caso del Vesuvio, che nella sua
storia eruttiva annovera range di manifestazioni energetiche molto diverse fra
loro (VEI3, VEI4 e VEI5), definire la portata dell’eruzione prima dell’eruzione
è puro azzardo, soprattutto se teniamo presente che la differenza tra i vari
indici di esplosività vulcanica è a progressione logaritmica.
La pianificazione d’emergenza ruota prima ancora che sull’eruzione
di riferimento sulla poco citata previsione ad excludendum dell’eruzione
massima conosciuta, che è una VEI5 (pliniana). Una teoria, quella dell’esclusione,
non supportata da premesse deterministiche ma solo probabilistiche su
un’analisi molto ridotta di dati disponibili.